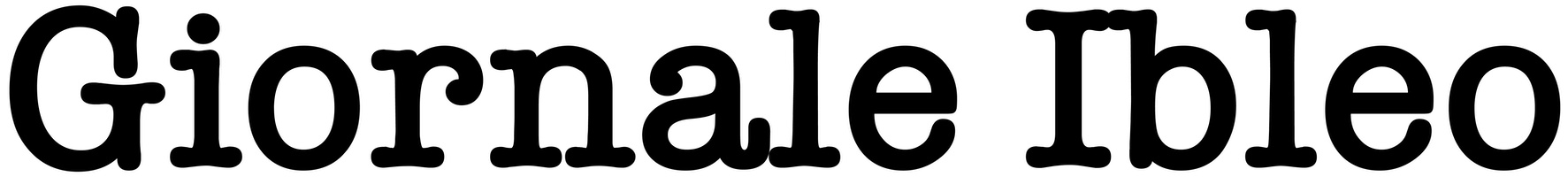Era la primavera del 1997 quando, a largo della Sicilia, tra Pantelleria e Capo Bon in Tunisia, il peschereccio chiamato “Capitan Ciccio”, del comandante Francesco Adragna, della flotta di Mazzara del Vallo, recupera dai fondali un particolare oggetto in bronzo ricoperto da numerosi molluschi: la parte terminale di una gamba, dal ginocchio in giù. Esattamente un anno dopo, nella notte tra il 4 ed il 5 Marzo del 1998, la stessa imbarcazione era intenta nel recupero delle reti cariche di pesci, da una profondità di circa 500 metri, e tirano su un busto bronzeo, mancante delle gambe e di un braccio. Inizia così una delle avventure più straordinarie dell’archeologia italiana, di cui è stato protagonista anche l’archeologo Sebastiano Tusa, morto tragicamente ieri in uno schianto aereo ad Addis Abeba. Sono davvero tantissimi gli studi condotti da Tusa: è ricordato principalmente per i suoi scavi a Mozia e a Pantelleria ma sicuramente merita un posto di rilievo nel panorama dell’archeologia italiana anche per il ritrovamento di un’opera straordinaria, oggi custodita a Mazara del Vallo: il Satiro Danzante, a cui è stato dedicato anche il museo in cui è tutt’oggi custodito.
Il Satiro arrivò a Roma il 2 Ottobre 1998 e fu sottoposto inizialmente ad indagini diagnostiche, allo scopo di capire la natura dell’opera e le problematiche che essa presenta, così da organizzare un restauro conservativo appropriato.
La figura del Satiro, ovvero un incrocio demoniaco tra un uomo ed una capra, abitante dei boschi e associato al Dio Pan, era una delle figure cardine delle rappresentazioni orgiastiche in onore di Dioniso. L’opera, infatti, presenta le tipiche orecchie a punta che caratterizzano la sua natura, nonché una originaria coda equina ormai andata perduta, di cui resta il foro di giuntura all’altezza delle natiche. La torsione del busto e il capo rivolto all’indietro, ricordano molto la celebre “Menade” di Skopas conservata a Dresda, in cui il corpo si abbandona all’estasi data dal sapore dolce e forte del nettare degli Dèi, dove le membra morbide si lasciano trasportare in balli sfrenati accompagnati da musiche allegre, ripetitive e penetranti.
Sebastiano Tusa contribuì al dibattito sulla datazione dell’opera: secondo l’archeologo siciliano, infatti, la nave che lo trasportava fece naufragio nell’area di mare tra Pantelleria e Capo Bon in Tunisia tra il III e il II secolo a.C. Nel 2018 era presente all’inaugurazione del nuovo progetto d’illuminazione, tutt’oggi attivo, presso il museo del Satiro. In quell’occasione, dichiarò: “Il Satiro danzante rappresenta un capolavoro dell’arte greca nel passaggio dallo stile severo alla “liberazione” della figura umana dell’ellenismo iniziale. La sua unicità risiede nella genialità del movimento vorticoso che avvolge nel vento sia il corpo che la stupenda capigliatura. Siamo certi che facesse parte di un carico di preziose opere d’arte forse trafugate da Alarico a Roma negli ultimi tragici giorni dell’impero”.
Ci piace ricordarlo così: un uomo dedito all’arte, alla cultura, alla conoscenza.