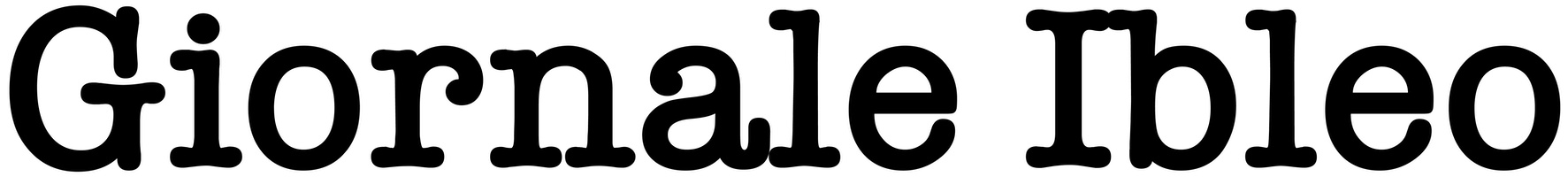Pienone al Centro ‘Feliciano Rossitto’ e non poteva essere diversamente, per la presenza di un personaggio storico della politica del secondo ‘900, come lo ha definito, con la sua gradevole introduzione, Giorgio Chessari.
Achille Occhetto, a Ragusa con la compagna Aureliana Alberici, è intervenuto alla presentazione dell’ultima sua fatica letteraria, “La gioiosa macchina da guerra, veleni sogni e speranze della sinistra”, che ripercorre le pagine della Svolta della Bolognina e della fine della storia del Partito Comunista Italiano.
Come è anche accaduto a chi ha letto le pagine del libro, ci si attendeva di rivivere, sia pure in maniera più distaccata, il dramma politico, storico e umano che caratterizzò la fine del partito.
Da alcuni considerata come l’ultimo grande atto della politica italiana, la svolta, che, forse, ancora, non è stata completamente metabolizzata, ha comunque perso, strada facendo, il suo spessore di fatto epocale.
E’ stato comprensibile cercare di rintracciare, attraverso le parole e gli umori dello stesso protagonista, quelle emozioni che potrebbero aiutare a capire quello che è successo.
Si è avuta l’impressione di un uomo colto, competente d politica, disilluso dagli anni e dagli eventi, consapevole di quel «bilancio passivo tra il bene elargito e il male ricevuto», di cui scrive, che è rimasto, fatalmente, legato a quelle vicende che hanno determinato la fine di un’epoca e instillato nei compagni, lui primo fra tutti, la speranza della rinascita della sinistra italiana.
Achille Occhetto ha fatto emergere la grande fatica psicologica che lo ha pervaso nella redazione dell’opera, lui che, da uomo della svolta è diventato l’uomo della grande sconfitta, la prima vittima di Silvio Berlusconi, l’uomo della ‘’gioiosa macchina da guerra’’, battuta giocosa scaturita da una parodia bellica a cui fu inchiodato, immeritatamente, dai suoi detrattori e dalla stampa di medio calibro.
Fra le parole di Occhetto si sono avvertiti segnali di una sofferenza latente, sentita ma ben arginata e sopportata, riferimenti a particolari che oggi la politica dovrebbe tenere in gran conto, come quando ha parlato di Calvino e di Pavese, definiti ‘’uomini che non avevano tanti voti, ma molto cervello’’.
Ma forse, appunto por questo, in un’epoca dove i voti fanno la differenza in barba alle capacità, alle competenze, alla cultura, l’incontro al ‘’Feliciano Rossitto’’ resta solo un appuntamento per vecchi nostalgici, non solo di sinistra, che hanno voluto godere di uomini, parole e fatti di altri tempi.